Il professore che amava i draghi
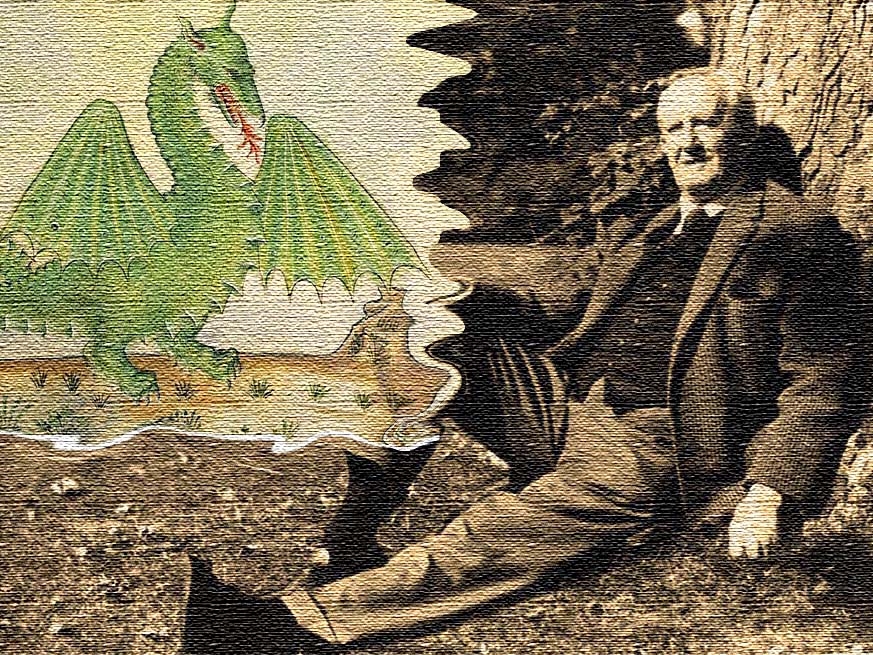
“«Evasione» viene oggi così spesso utilizzato: un tono per il quale gli usi della parola al di fuori della critica letteraria non forniscono giustificazione alcuna”.
Non è l’unica tagliente osservazione di J.R.R. Tolkien (1892 – 1973) sulla miopia accademica e “modernista” verso tutto quanto è “fantasia”.
Essa è contenuta nell’intervento Sulle fiabe, pubblicato nella raccolta Il medioevo e il fantastico (edizione italiana a cura di Gianfranco De Turris, traduzione di Carlo Donà, Bologna 2003, Bompiani).
Il titolo originale della silloge è: The Monsters and the Critics and Other Essays (1983).
Fu curata come opera postuma da un figlio di J.R.R. Tolkien, Christopher.
I saggi in essa contenuti testimoniano della passione che portò l’autore a salire sulla cattedra di Anglosassone a Oxford.
Tutto cominciò così: “…io desideravo i draghi con desiderio profondo” (p. 201).
Da quell’attrazione infantile, Tolkien passò ai poemi in antico inglese, ricchi di mostri, come quel Beowulf a cui sono dedicati due saggi della raccolta.
Il matrimonio fra la vocazione al fantastico e la filologia fu inevitabile. Quel mondo meraviglioso sarebbe stato inaccessibile, senza conoscerne la chiave, la lingua in cui esso si esprimeva.
Da cui la finezza analitica di Tolkien nel percorrere la storia dei vocaboli, e il suo Vizio segreto: inventare idiomi.
Il desiderio di esplorare Faërie, “il mondo fatato” costruito dalle parole, si configura come inquietudine di uno spirito vigile. “Io non avevo nessun particolare infantile «desiderio di credere».
Io volevo sapere.” (p. 200).
Tuttavia, la dimensione del desiderio era per lui essenziale, nella fiaba: “La fantasia, il creare o far intravvedere Altri Mondi; era il cuore del desiderio del Fiabesco.” (p. 201).
L’evasione offerta da esso era, per Tolkien, la legittima resistenza del prigioniero contro le mura della cella (cfr. p. 218).
Fuor di metafora, interessarsi ai poemi medioevali e alla loro lingua era un modo per combattere la bruttezza dell’Inghilterra industrializzata, che cercava il “progresso” nella distruzione delle campagne e nella vita degradante destinata al proletariato urbano.
“Perché dopotutto è possibile per un uomo razionale […] arrivare alla condanna […] di cose progressiste come le fabbriche, o le mitragliatrici e le bombe, che sembrano essere i loro prodotti più naturali e inevitabili…” (pp. 220-221).
La malattia degli inglesi moderni era, ad avviso di Tolkien,
l’essere “acutamente consapevoli sia della bruttezza delle nostre opere, che della loro malvagità” (p. 222).
Se non poté evitare lo squallore nel mondo del lavoro e nelle infrastrutture, il professore fu però in grado di regalare bellezza con opere letterarie di cui il Novecento sarebbe sembrato incapace.
E di mettere mano a una riforma dell’insegnamento universitario, per porre fine alla curiosa separazione fra lo studio della letteratura e quello della filologia (Discorso di commiato all’Università di Oxford, pp. 319-340).
Tolkien bollò la disciplina accademica dell’Anglistica come “macchina da insaccati” (p. 322) e si scagliò contro quelli che chiameremmo “baroni”, accusandoli di “erigersi una piramide con il sudore di schiavi laureati” (p. 323).
La rivoluzione di Tolkien è, ancora una volta, all’insegna del desiderio, di quel “bisogno di conoscenza” senza il quale non c’è grandezza intellettuale e che permette di distinguere le università dai salumifici.
La rivolta della fantasia ha esito positivo: congedandosi da Oxford, Tolkien contempla allievi e potenziali successori. “…il duguð (= la corte) non è ancora caduto presso le mura, e […] il dréam (= suono di festa) non è stato ancora ridotto al silenzio.” (p. 340).
(elaborazione foto Roberto Roverselli per CaffèBook)
Leggi anche Donne che corrono coi lupi