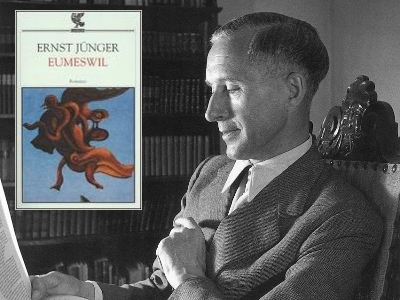Sopravvivere a Eumeswil, ovvero Cerca il trilobite

Un futuro imprecisato, dopo il crollo di ogni ideologia, in una regione guidata da un tiranno il cui titolo è “Condor”.
Questo è il quadro di Eumeswil (1977), una delle opere più tarde di Ernst Jünger (Heidelberg 1895 - Wilflingen 1998).
L’opera mantiene quel senso della catastrofe epocale e della solitudine aristocratica che ha reso famoso lo scrittore, oltre che controverso. Pur avendo frequentato circoli rivoluzionari d’ispirazione nazionalistica, non aderì al nazismo e rifiutò la nomina all’Accademia prussiana (1934).
Libri di
A diciassette anni, tentò la fuga in Africa e l’arruolamento nella Legione straniera. Nel 1914, fu volontario di guerra e rimase ferito quattordici volte, anche gravemente. Nel 1923, lasciò l’esercito e iniziò a studiare zoologia e filosofia (prima all’università di Lipsia, poi a quella di Napoli).
Dal 1941 al 1944, fu ufficiale a Parigi, presso il quartier generale delle truppe dislocate in Francia.
Ne fu allontanato dopo la pubblicazione del suo Der Friede (= “La Pace”), utopico appello alla pace indirizzato ai giovani.
La sua opera attraversò diverse fasi, dall’esaltazione di ogni prova di forza (anni ’20), al titanismo antiborghese (anni ’30), fino alla critica del terrorismo tirannico (fine anni ’30). Quest’ultima contribuì a renderlo inviso al regime nazista, che pure lo “corteggiava” con offerte di carriera politica e di pubblicazioni.
Nel secondo dopoguerra, Jünger accentuò - nelle proprie opere - l’aspirazione alla pace e alla libertà.
Principalmente saggista, scrisse anche opere narrative dal linguaggio complesso, in cui si esprime al meglio il suo astoricismo.
Astorica (e ageografica) è l’ambientazione di Eumeswil:
come si diceva, un quadro desolante, in cui nessun valore sembra più credibile. Ma proprio in questo deserto sboccia un fiore raro: l’Anarca.
Esso è impersonato da Martin Venator, storico di professione, nonché steward nel bar notturno della casbah, la cittadella ove risiede il Condor con la sua corte. Grazie a questa sistemazione, Martin può accedere al Luminar, l’ambiente ove vengono rievocati fatti e personaggi del passato - con una tecnologia imprecisata che ha un che di magico.
Il suo nome unisce la radice di “Marte” al termine latino per “cacciatore”. L’Anarca di Jünger è quindi uno spirito fondamentalmente combattivo. Ma il Condor preferisce chiamarlo “Manuel”, perché dal suono più dolce. Una delicatezza singolare in un signore che si è guadagnato il potere con le armi, nota Venator - ma forse nemmeno troppo.
Può essere un modo di negare la capacità di lotta di un potenziale avversario. Perché l’Anarca sarebbe perfettamente in grado di uccidere e regnare, se lo volesse. Non lo fa, perché è già libero. È lontano dal tiranno e dal monarca - moralmente, se non fisicamente - e tratta entrambi come semplici fonti storiche utili al suo lavoro. È il Condor a dover temere Martin, non viceversa.
La natura combattiva del protagonista è sottolineata dal paragone fra lui e Senofonte (Atene, 430 - 354 a.C. ca.), nelle ultime pagine del romanzo. Senofonte è infatti famoso per essere stato non solo uno storico, ma anche un attore dell’epoca che immortalava: combatté nella guerra del Peloponneso, come mercenario al fianco di Ciro il Giovane, come filo-oligarchico col re spartano Agesilao, venendo esiliato per le sue scelte.
Gli ideali militari e nobiliari di Senofonte ricordano il giovane Jünger.
La città immaginaria di Eumeswil, a sua volta, contiene un altro nome noto: “Eumene”. È impossibile non ricordare che è omonimo di Eumene di Cardia (360 circa - 316a. C.), generale greco al servizio della monarchia macedone. È noto per aver seguito l’impresa di Alessandro Magno e per averne redatto uno dei resoconti più asciutti e meno celebrativi, le Efemeridi.
Di questo carattere è anche la storiografia di Venator, che ama mettersi nei panni di ciascuno dei personaggi evocati al Luminar, soppesarne le opposte ragioni, riportarle senza significati aggiuntivi. Paradossalmente, proprio quest’incapacità di parzialità e cortigianeria ha fatto di Martin uno dei prediletti dal tiranno:
“…la dedizione incondizionata è pericolosa. Un politico, un autore, un attore viene ammirato da lontano. Finalmente si perviene all’incontro con l’idolo - come persona non può reggere all’aspettativa. È facile allora che l’amore cambi. […] Insieme con le vesti, viene a cadere anche la divinità.” (E. Jünger, Eumeswil, Parma 2001, Ugo Guanda Editore, p. 37.Traduzione di Maria Teresa Mandalari).
Il segno più evidente della natura tirannica del regime è il fatto che, a Eumeswil, la microacustica abbia raggiunto livelli inimmaginabili:
“Esistono zone in cui non si osa nemmeno bisbigliare: vi può esser collegato pericolo di morte.” (Idem, p. 130).
Il nome di Eumene è legato anche a un’altra caratteristica della città: il fatto di essere “un impaludamento fellahoide su fondamenta alessandrine” (per “fellah”, si veda oltre, in questo articolo), idem, p. 29. Essa è una società disfatta, senza valori, ma posata su quanto resta della sapienza antica.
A questo si ricollega un simbolo che compare verso l’inizio del romanzo: il trilobite.
“Se prendo in mano un fossile, ad esempio un trilobita […] mi affascina l’impressione di armonia matematica. Finalità e bellezza, fresche come il primo giorno, coesistono tuttora intatte in una medaglia incisa da mano maestra.” (Idem, pp. 29-30).
 |
Quel giudice dei morti che è lo storico non può ridar la vita a ciò che è ormai fossile, ma sente - a ogni modo - di essere su tale via. Lo splendore immortale dell’antico è, del resto, l’unica cosa per cui valga la pena di vivere nella distopia di Eumeswil.
Venator, il cacciatore di autorevolezza, di verità e di fatti remoti, discende da una famiglia di storici, bensì come figlio illegittimo. Ciò sembrerebbe spiegare la sua lontananza spirituale dal padre e dal fratello, entrambi liberali “vecchio stampo”, che lui critica come rimasticatori di slogan senza più nerbo. Non molto spazio di azione sembra rimasto a quelli come loro, se non le chiacchiere: ed esse, per l’appunto, sono sacre a entrambi. “Che la libertà abbia inizio là dove ha fine la libertà di stampa non entrerebbe in testa al mio fratellino. «Libertà di pensiero» - - - significa ch’egli, con le sue idee stantìe, non osa avventurarsi al di là della riserva di caccia. […] Anche le idee buone fanno il loro tempo. Il liberalismo sta alla libertà come l’anarchismo all’anarchia.” (Idem, p. 155).
L’Anarca non rimpiange la decadenza delle idee, perché non si attacca a esse, ma ai fatti. Se soffre per l’esito di un’azione, soffre quando sa che l’errore è stato responsabilità sua, non per il fallimento del sogno in sé. Non è nemmeno uno sprezzatore dell’autorità, o - meglio - dell’autorevolezza: “ne vado in cerca, e proprio per tal ragione mi riservo il diritto di esame.” (Idem, p. 237).
Tipi umani certamente opposti all’Anarca sono i cosiddetti “eunuchi”, “quelli armati solo di belle frasi” (ibid.). Così come i “furfanti”, hanno perduto la propria storia e - pertanto - possono solo ridursi all’opportunismo. Il loro bisogno più intimo è “castrare l’uomo libero” (p. 243): fanno varare leggi secondo le quali “si dovrebbe correre dal procuratore della repubblica, mentre viene violentata vostra madre” (ibid.).
Ma anche dagli anarchici propriamente detti Venator si sente lontanissimo.
“L’anarchista, nemico nato dell’autorità, s’infrangerà contro di essa dopo averla più o meno danneggiata. L’anarca, invece, si è appropriato dell’autorità: egli è sovrano.
Pertanto si comporta di fronte a Stato e società come una potenza neutrale.
Ciò che vi avviene, può piacergli, dispiacergli o essergli indifferente. Lo stabilisce la sua condotta: egli non vi investe valori sentimentali. […] L’anarca […] conosce le regole del gioco. Le ha studiate da storico e vi si inserisce da contemporaneo.” (p. 241).
Non è nemmeno un individualista: non gli interessa mettere in luce la propria personalità, presentarsi come “grand’uomo” o “spirito libero”. “La sua misura gli è sufficiente; la libertà non è la sua méta: è sua proprietà. Non interviene né da nemico né da riformatore: sia in capanne che in palazzi si andrà bene d’accordo con lui. La vita è troppo breve e troppo bella per sacrificarla alle idee” (p. 269).
Caricarsi sulle spalle le conseguenze delle proprie azioni, per l’Anarca, è una semplice accettazione di quelle “regole del gioco” che dicevamo: un fatto di correttezza, come lo è - in una partita di scacchi - terminare mantenendo i pezzi bianchi o neri scelti all’inizio. Esclude, in ogni caso, l’impeto missionario:
“Per quanto riguarda i riformatori del mondo, conosco bene gli orrori commessi in nome dell’umanità, del cristianesimo, del progresso. […] L’uomo non è né bestia, né angelo; ma diventa un demonio quando pretende di diventare un angelo.” (p. 139).
Pertanto, se è evidente la distanza fra l’Anarca e gli anarchici, lo è ancor più quella fra lui e i socialisti:
“La loro lotta non è condotta contro il potere, ma per il potere.” (p. 307).
E questo porta alle conseguenze citate da Venator durante una sua ricerca bibliografica: “«Qualsiasi cosa affermino o neghino i socialisti di Stato, il loro sistema, se accettato, è condannato a condurre una religione di Stato, di cui tutti pagheranno le spese e dinanzi al cui altare tutti devono inginocchiarsi […] ad un codice morale statale, che non si contenterà della punizione del crimine ma reprimerà anche tutto ciò che la maggioranza vorrà qualificare come vizio […] Così, l’autorità raggiungerà il culmine e il monopolio il dispiegamento supremo del suo potere.»” (p. 315).
Tale ossessione di controllo è alla radice di quel disprezzo per il piccolo-borghese di cui abbiamo parlato nel trattare di P.J. Proudhon:
“Come avviene che il piccolo-borghese venga trattato in parte da spauracchio in parte da testa di turco dagli intellettuali, dalla grande borghesia, dai sindacati? Probabilmente, per il fatto ch’egli rifiuta di farsi costringere, sia dall’alto come dal basso, a far marciare la macchina. Se proprio non si può fare diversamente, prende egli stesso in mano la storia.” (p. 314).
La collocazione astorica e ageografica di Eumeswil è sottolineata dalla terminologia, che prende in prestito forestierismi e radici greche o latine. Sono forse un ricordo dell’avventura giovanile nella Legione straniera le parole arabe ricorrenti:
“casbah”, per indicare la cittadella fortificata ove vive il Condor;
“fellah”, per designare quegli abitanti di Eumeswil che vivono passivamente contesi fra demagoghi, tirannide e tribuni.
A questi ultimi, Venator riserva osservazioni particolarmente pungenti.
I tribuni hanno infatti boicottato quel modo semplice di vivere che l’Anarca apprezza e che garantisce il sostentamento delle persone umili.
“Anche il sale [i pescatori] lo traggono dal mare, grattandolo dai crepacci e dalle cavità della roccia, dove si cristallizza. Sotto i tribuni, era proibito; avevano regolamentato tutto appuntino, fino alle minuzie.
Il sale, il cui prezzo si era centuplicato, doveva essere acquistato nelle loro tabaccherie. Vi facevano aggiungere anche altre materie che i loro chimici vantavano come benefiche, sebbene risultassero poi nocive.
Che cervelli siffatti ritengano di essere dei pensatori, è perdonabile; ma pretendono di essere anche benefattori. […] I tribuni erano dei ridistributori; rincararono ai poveri il pane per renderli felici con le loro idee - ad esempio, costruendo dispendiose università, i cui diplomati disoccupati risultarono di peso all’assistenza pubblica, cioè a lor volta ai poveri, e si rifiutarono di prender più in mano un martello.
Il povero, fintanto che non abbia una mentalità da parassita, vuole vedere il meno possibile lo Stato, qualunque siano i pretesti sotto cui gli si mostra” (pp. 207 - 208).
Martin Venator, a suo modo, riuscirà a sopravvivere all’assurdo universo di Eumeswil.
Terminerà la partita muovendo i pezzi che ha scelto, fino in fondo. E questo porterà al suo più grande risultato esistenziale: “il completo distacco dalla esistenza fisica. Mi scorgevo allo specchio come aspirante alla conoscenza sovrasensibile - - - me stesso, in confronto, come suo fugace riflesso” (p. 368).
La chiusura del romanzo è un colpo di scena: l’ultimo a parlare non è Venator, che ha narrato tutto in prima persona, ma suo fratello, nell’atto di sigillare gli appunti rinvenuti. Protagonista vera è dunque la Storia, intesa come resto scritto, che può anche essere parziale, ma obbliga la coscienza dello storico a conservarlo per quel che è. La lezione del Trilobite.